laR+
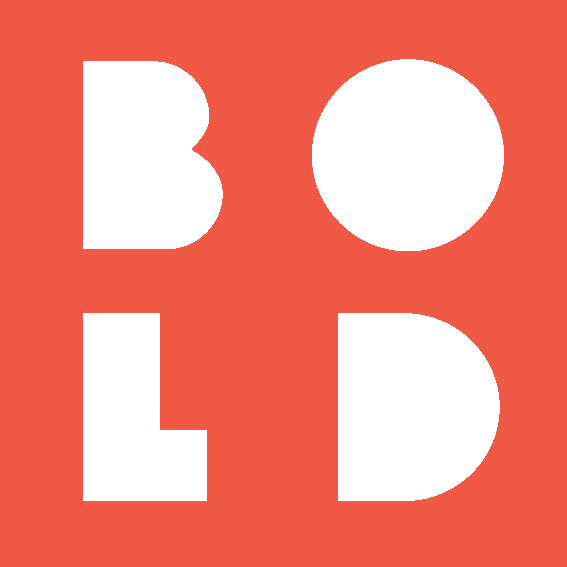
Più fatti e meno parole? ‘No, siamo tuttƏ ciò che diciamo’
Conta più come ci si comporta o il modo di esprimersi? Le voci di alcuni liceali sulle questioni di genere e l’intervista alla sociolinguista Vera Gheno
Vera Gheno, sociolinguista
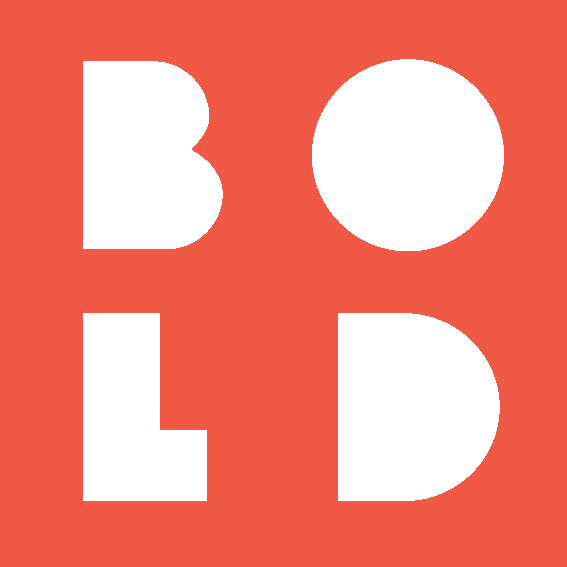
Conta più come ci si comporta o il modo di esprimersi? Le voci di alcuni liceali sulle questioni di genere e l’intervista alla sociolinguista Vera Gheno