laR+
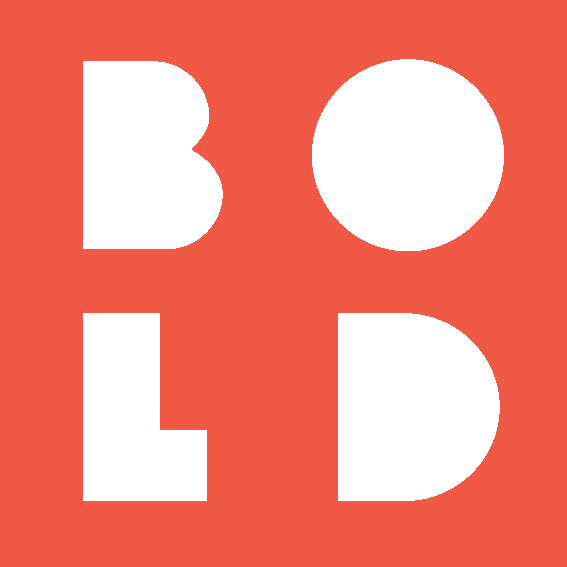
11 settembre, vent'anni di macerie e cicatrici
Alcune riflessioni su quegli attacchi che per un attimo erano parsi un incidente, e su quello che venne dopo, con uno storico che c’era
((Keystone))
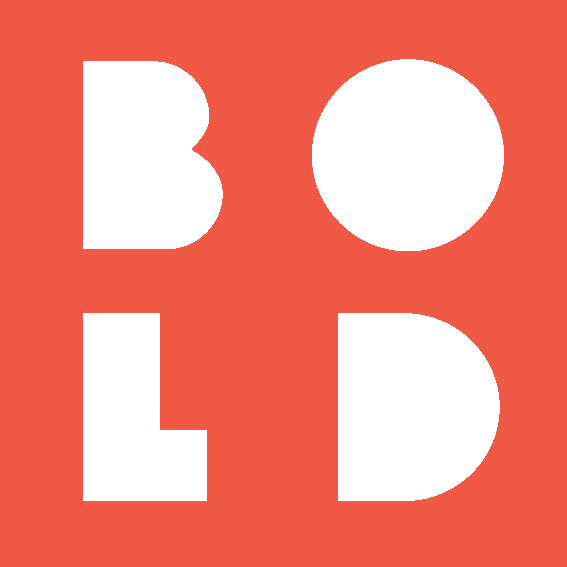
Alcune riflessioni su quegli attacchi che per un attimo erano parsi un incidente, e su quello che venne dopo, con uno storico che c’era