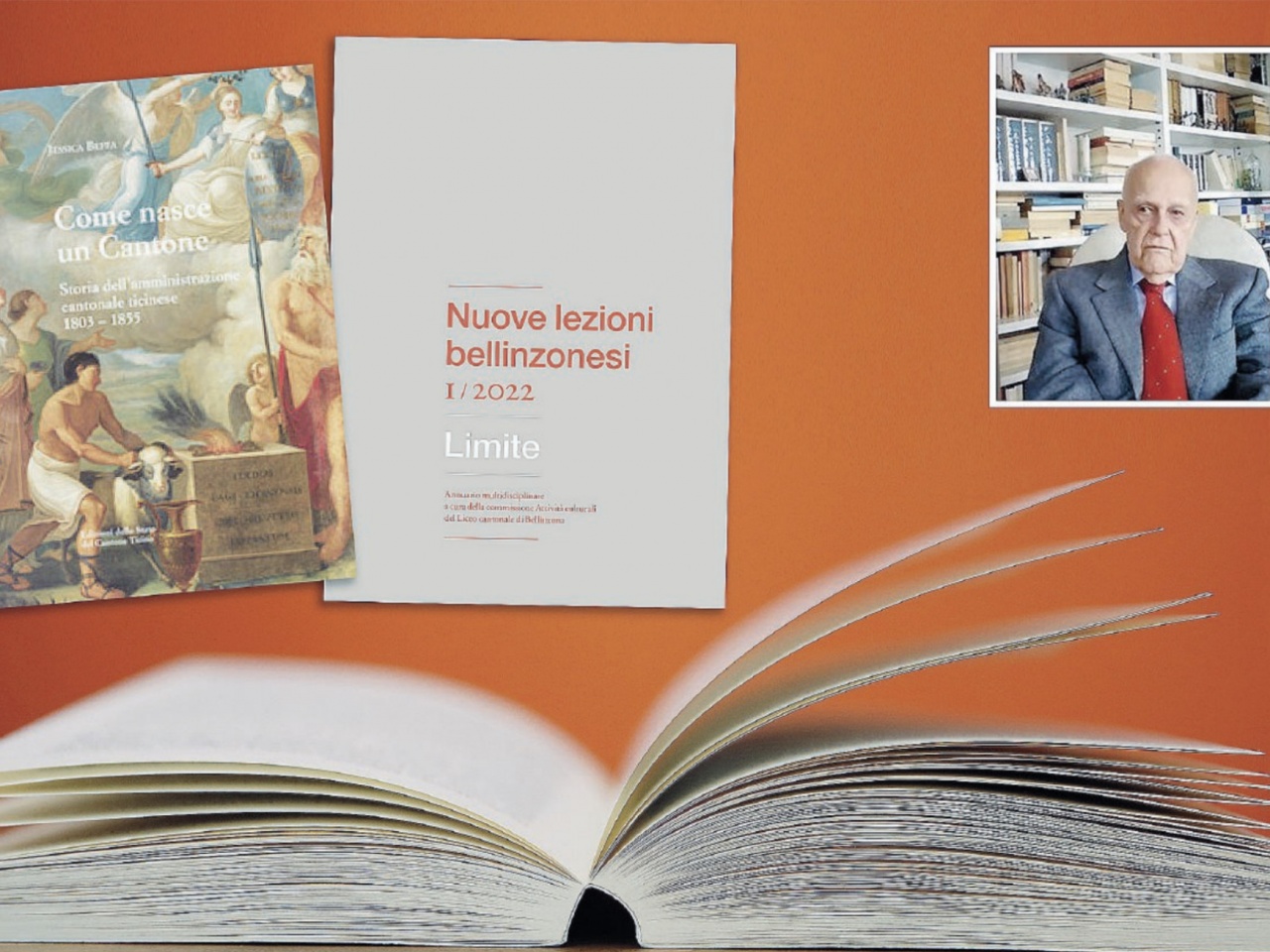Cinquantadue ritratti e una sintesi di Bianciardi
Gli scritti giornalistici dell’intellettuale italiano in un libro. Nell’altro, una manciata d'italianisti decisivi, nati nell’arco di un ventennio.

Pubblichiamo contenuti da ‘Otium’, pagina culturale a scadenza mensile
1
Luciano Bianciardi oggi
di Arnaldo Bruni, storico della letteratura
Di Luciano Bianciardi (Grosseto 1922-Milano 1971) si è molto parlato quest’anno in occasione del centenario della nascita, al punto che il suo nome è sembrato il più pertrattato dopo quello di Pier Paolo Pasolini, suo collega di centenario, che pure come poeta, romanziere e regista cinematografico può vantare titoli di merito più agevolmente riconoscibili. La singolarità invoglia a indagare i motivi di tanta attenzione, aiutando ora per giunta una novità vistosa emersa in conclusione dell’anno commemorativo: la pubblicazione in tre volumi (più un’appendice di Indici), per iniziativa della figlia Luciana, di tutti i suoi articoli sparsi, Tutto sommato. Scritti giornalistici 1952-1971 (Milano, ExCogita, 2022). L’opera riunisce tutti gli scritti finora non raccolti, sostituendo l’antologia precedente (L’Antimeridiano del 2008), con un’aggiunta di più di quattrocento pezzi. Se è vero che la quantità, a certi livelli, diviene qualità, non si può negare che un’addizione così massiccia investa l’immagine dell’autore, arricchendone il profilo fino a prospettarne aperture inattese. Il caso suscita curiosità e sollecita una veloce ricognizione. Non c’è dubbio che la saggistica costituisca, insieme con i romanzi e con il lavoro di traduzione che gli ha consentito di sopravvivere da free lance, la spina dorsale del suo impegno intellettuale. I romanzi peraltro sono strettamente embricati con la scrittura ebdomadaria per sua stessa ammissione, stando alla confessione di una lettera a un amico: “i miei cosiddetti romanzi in realtà sono dei saggi travestiti”.
La definizione è calzante, se si osserva la sua attività autonoma, dopo I minatori della Maremma, scritto in tandem con Carlo Cassola (1956). Il lavoro culturale (1957) è il resoconto della sua stagione provinciale a Grosseto, dopo la sua emigrazione a Milano per concorrere alla fondazione della casa editrice Feltrinelli. Gli acidi della sua ironia, applicata a un’esperienza personale così coinvolgente e appena trascorsa, collaborano di concerto alla confezione di uno spassoso pamphlet che assume come linea privilegiata la critica alle forme del linguaggio politico vigente, nella fattispecie identificate con le convenzioni del Partito comunista italiano: a norma di una predilezione che segnala modalità agevolmente estensibili ad altri ambiti futuri. La radice autobiografica costituisce il motivo conduttore principale della sua ricerca, precisata nel 1960 ne La integrazione, romanzo accostato di solito alle prove di Lucio Mastronardi e di Paolo Volponi come prodotto di letteratura industriale, nel suo caso agganciata però a una vicenda vissuta in prima persona. Nel racconto affiora la delusione per l’esperienza dell’impiego in Feltrinelli, con un dosaggio stilistico che modula fino al sarcasmo quella maniera umoristica, in accezione pirandelliana, divenuta ormai cifra personale. La modalità ritorna, con un voltaggio di accresciuta intensità, nel suo capolavoro, La vita agra (1962), che assume a pretesto la biografia tormentata di un traduttore a cottimo per decostruire la società milanese del boom economico, anticipando nella sua critica lungimirante le ragioni di una crisi destinata a maturare nei tempi lunghi dei giorni attuali. Ma la ricerca, va precisato, non si risolve solo nella scarnificazione della realtà contemporanea, si giova anche di un retroterra storico connesso con la sua passione risorgimentale, esplicitata nel racconto della spedizione dei Mille, Da Quarto a Torino (1960).
Lo sviluppo dei due livelli, la critica alla contemporaneità e il richiamo al Risorgimento, comporta l’elaborazione di una traiettoria di lavoro che mira alla fusione dialettica dei due piani coltivati. L’obiettivo già presente ne La battaglia soda (1964), in cui il protagonista assume le sembianze di un suo eroe dell’infanzia, il conterraneo Giuseppe Bandi, luogotenente di Garibaldi, che viene messo alla prova in occasione della battaglia di Custoza (1866), definita con un titolo di ascendenza machiavelliana. Il proposito di attualizzazione della dimensione storica risulta accusato nell’ultimo romanzo, l’ucronico Aprire il fuoco (1969), in cui immagina di spostare nel 1959 i moti di Milano del 1848, mescolando in un missaggio di tipo cinematografico personaggi storici, tra gli altri Carlo Cattaneo e Carlo Tenca, e personaggi contemporanei, come Giorgio Bocca e Camilla Cederna: tutti chiamati a partecipare a una rivoluzione immaginaria, in sintonia con la stagione del Sessantotto.
A questo sommario ritratto, che propone il profilo di un irregolare con deriva anarchica, che cosa aggiungono finalmente i saggi citati all’inizio? Direi non poco. Intanto emergono nella varia casistica gli estri incontenibili di un autore dotato di uno straordinario orecchio sociologico, capace di individuare con sicurezza le novità emergenti nel quadro di una cultura indagata tramite una lucida radiografia analitica. In particolare vengono sottoposti a verifica, nella sua collaborazione a ben 63 testate, i programmi della televisione, a cui dedica rubriche specifiche contro il disinteresse allora diffuso per un mezzo giudicato di qualità inferiore. Ancora, scrive con divertita adesione di sport sul Guerin sportivo di Gianni Brera, privilegiando ciclismo, calcio e pugilato. Di più, non distoglie lo sguardo dalla cronaca quotidiana, esercitando uno scrutinio serrato sulla fenomenologia corrente, rivisitata alla luce di istanze libertarie. Si tratta di temi ancora al centro del dibattito contemporaneo ritornanti nelle colonne dei quotidiani e delle riviste in edicola. Non c’è dubbio che la bruciante sovrapposizione fra il resoconto dello scrittore e l’attualità palpitante dei nostri giorni consenta di riconoscere, in questa insolita convergenza, il motivo vero che invoglia molti appassionati a rivisitare a distanza di decenni l’originalità della sua opera.
2
Grandi italianisti nati tra 1920 e 1940
di Gilberto Lonardi, storico della letteratura
Ecco un volume tutt’altro che di routine*. Si coglieranno subito la costruzione e l’angolazione originale. E, si spera, benvenuta. Il libro è costruito coralmente: cinquantadue ritratti, né troppo brevi né, soprattutto, troppo lunghi, di personalità critiche che, nate tra 1920 e 1940, hanno diffuso e anche imposto la loro attiva, a volte attivissima presenza in Italia, e anche in Svizzera, «tra lingua e letteratura, filologia e strutturalismo, teoria e comparatistica, psicanalisi e sociologia, narratologia e semiologia ed estetica della ricezione». Nessun effetto di schiacciamento o di affollamento. Nessuna ripetitività. Da Cesare Cases a Romano Luperini è un’intera, complessa storia degli studi letterari quella che si squaderna, variissima e dunque sempre o quasi sempre, capitolo dopo capitolo, accattivante, sotto i nostri occhi. E il termine cultura non basta, se spesso si impongono passione, novità metodologica, astuzie dell’intelligenza, stile degli effigiati.
Dico qualcosa, intanto, sui ritrattisti. Spigolare da pagina a pagina consente l’incontro con nomi anche ben noti, da Residori, per dire, a Scaffai, e con altri che lo sono meno ma tutti impegnati a prendere le misure del proprio oggetto con concretezza e chiarezza – certo, pure al riguardo in dosi non eguali -: ciascuno a dire molto, stando quasi sempre all’essenziale.
E i personaggi? Impressionante soprattutto il triennio d’avvio, quello dei nati tra 1920 e 1923. Basterebbe, tanto per cominciare, l’ elenco: Cesare Cases, Gianfranco Folena, D’Arco Silvio Avalle, Domenico De Robertis, Dante Isella, Adelia Noferi, Sergio Romagnoli, Giovanni Pozzi, Sebastiano Timpanaro. Non tutti i contributi sono all’altezza dell’oggetto. Ma è l’insieme che, con alcuni e non pochi acuti, va considerato eccellente. E dunque è raccomandabile, magari dopo un primo assaggio qua e là, come ho fatto io, antologico, la lettura per intero.
Fra i do di petto – i miei scarni cenni finiranno però per tradire la complessità e ricchezza di molti contributi - vedi per esempio il robusto intervento di Luca D’Onghia su Folena. Con un incipit che già dice molto: «La radice quadrata della sua attitudine critica può essere colta anche negli scritti apparentemente più tecnici e meno letterari»; e «Succede così che […] l’esame tecnicamente agguerrito dei testi si accompagni sempre a un’intensa percezione della loro storicità e delle concrete occasioni della loro genesi e della loro circolazione». O vedi il terso viaggio di Scaffai dentro il lavoro e anzi i lavori sempre ‘in corso’, in un fieri appassionato e appassionante, di Dante Isella (anche se la iselliana citazione conclusiva appare, ahi, tristemente utopica, nel suo taglio di speranza umanistica). E di tutto rispetto il De Cristofaro su padre Pozzi, «inquieto osservatore delle ideologie molteplici che soggiacciono alle forme»: con una sua curiosità e mobilità perfino inattesa, tra amato Seicento e presente letterario e figurativo, oltre che poetico.
Una sorpresa spiazzante, almeno per me, ma non privo di insegnamenti sul personaggio Timpanaro, è il contributo, comunque molto parziale, di Dalmas: basti dire che privilegia, sullo studio dell’Ottocento e di Leopardi, Il lapsus freudiano: ma con ‘ritorni’ su parte almeno della complessa attività timpanariana, tra filologia, storia letteraria, pronunciamenti filosofico-ideologici.
E poi, dopo quel formidabile triennio natale? Qui procederò sparsamente, scusandomi per certi silenzi, che non implicano affatto disattenzione, e piuttosto vogliono evitare la stanchezza in chi mi legge. Per il dopo, che riguarda comunque attori come Raimondi o Agosti o Sanguineti o Claudio Magris, tutti con cura effigiati, e ancora altri valorosi e valorosissimi, direi che forse compete troppo col modello l’Agazzi di Citati. E che qualcosa di più, una messa a fuoco più adeguata, spettava a Mengaldo. Tra quelli che più personalmente ho apprezzato metterei invece, fra altri, Donati su Piero Camporesi, Lazzarin su Francesco Orlando, Marco Villa su Gian Luigi Beccaria, Pellini su Luigi Blasucci, Palumbo su Eduardo Saccone. E una particolare menzione riserverei per Simonetti, su Cesare Garboli (con lui è lo stile, osserva Simonetti, che salva dal narcisismo: ma col narcisismo, quando è di qualità ed esplode, come con Garboli, in conoscenza, io sarei anche più condiscendente).
Che più? Invoglino pure i nudi o quasi nomi che ho fatto, così spero, alla lettura delle pagine che loro competono. Aggiungo la cifra, la più evidente e forse unica, e cifra efficace, che lega insieme i cinquantadue ‘pezzi’: i quali tutti partono, alla Auerbach, da un estratto d’autore particolarmente significativo. Un modo per riuscire concreti e il più possibile chiari, entrando subito in casa del critico (eccellente, al riguardo, ma sarebbe di cattivo gusto insistervi, l’ingresso di Ida Campeggiani per quanto riguarda chi scrive).
*La critica viva. Lettura collettiva di una generazione. 1920-1940, a cura di L. Curreri e P. Pellini, Quodlibet, Macerata 2022, pp. 356.