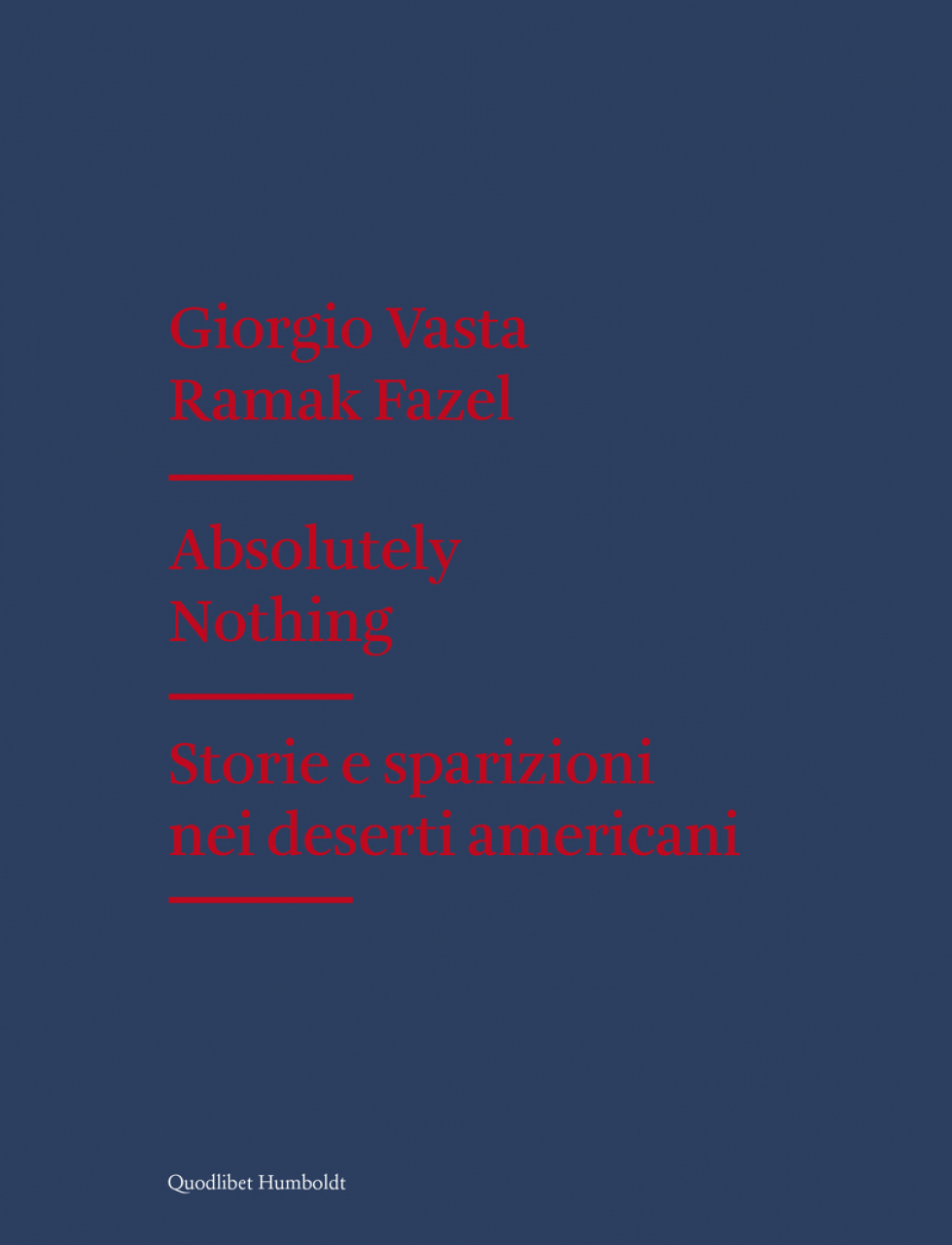Dentro i deserti di Giorgio Vasta
Babel in versione 'Atlantica' ha incluso anche il punto di vista dello scrittore palermitano di 'Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani'

Tra le molte implicazioni, tutte rigorosamente letterarie, l’accezione ‘Atlantica’ ha reso imprescindibile che lo sguardo a cavallo tra Europa e Americhe di Babel 2020 includesse anche il punto di vista del palermitano Giorgio Vasta, affermatosi col romanzo 'Il tempo materiale' (uscito in 11 nazioni, tra i selezionati del Premio Strega 2009), anche 'penna' delle pagine culturali di Repubblica, Il Sole 24 Ore e Il Manifesto. La 'sua' America è il viaggio del 2013 divenuto libro nel 2016, intitolato 'Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani' (Humboldt/Quodlibet 2016), una raccolta di appunti anche visivi (affidati gli scatti del fotografo Ramak Fazel) delle "reliquie dell'abbandono" dei grandi spazi statunitensi. Deserti ritratti tramite un insieme di scrittura documentaristica e fiction; deserti tornati di estrema attualità nella più recente forma di abbandono cittadino, in questo caso forzato, chiamata 'lockdown'.
Giorgio Vasta. Era il suo primo viaggio negli Stati Uniti?
Non era il primo viaggio in assoluto. Ero già stato in quel luogo a sé che è New York. Al contrario del primo, questo secondo viaggio ha toccato sempre la provincia più remota, la più dimenticata, in cui le metropoli, le grandi città non comparivano mai o quando comparivano. Come nel caso di Las Vegas, per esempio, dove il nostro tempo è trascorso visitando un museo dedicato ai neon, che la città ha compreso essere il suo monumento più rappresentativo. I neon delle sale da gioco, dei casinò, delle cappelle nelle quali ci si poteva istantaneamente sposare hanno caratterizzato lo spazio fisico, generato un immaginario per poi essere abbandonati in un pezzo di deserto. Gli americani si sono resi conto che era importante recuperarli ed è stato creato un museo a cielo aperto in cui il visitatore passeggia in mezzo a parole deposte in mezzo alla sabbia. Ed è stata un’esperienza molto bella.
Lei parla di “dimensione dell’abbandono”, di “tecnica dell’abbandono”. Chiedevo se fosse il primo viaggio per capire la sua reazione di fronte a una realtà ben diversa da quella sognata, per citare le disillusioni di Jackson Browne, “in books and films and songs”…
È un’esperienza che, in modi diversi, si determina tanto nelle grandi città quanto nella provincia, nei deserti, nelle praterie, in tutti quei luoghi che io e penso buona parte degli europei abbiamo conscoiuto attraverso la sua rappresentazione letteraria, cinematografica, televisiva, una sensazione comune a molti, quel “Io qui ci sono già stato”, perché si è stati attraverso la visualizzazione dei luoghi mentre si legge un romanzo o la visione letterale degli spazi mentre si guarda un fim, un telefilm, oggi una serie tv. Quello che mi ha colpito, però, ed è accaduto all’inizio del viaggio già a Los Angeles, è stato a Venice Beach: ero certo che una volta che avessi messo il piede nell’acqua di una spiaggia così importante negli anni Sessanta, dove s’incontrarono, per esempio, i fondatori dei Doors, questo posto si sarebbe distaccato dalla sua rappresentazione e si sarebbe guadagnato una sua autonomia e una maggior complessità. Quello che invece è accaduto, e all’inizio mi era parso un dispiacere, è stato che la rappresentazione di questi spazi è così potente che quando oggi penso a Venice Beach e a tanti altri luoghi degli Stati Uniti, prima del ricordo della mia presenza in quello spazio c’è l’immagine narrativa, come se le narrazioni fossero più forti, più potenti e determinanti nelle percezioni che abbiamo di quei luoghi.
Più forti della realtà?
Si tratta di riconoscere che il legame che abbiamo da esseri umani con la finzione è inesauribile e in un certo senso inarginabile, che non può essere circostritto a un momento specifico. Quando ci si muove, e porto l'esempio dei marciapiedi di Los Angeles, senti la falcata farsi famelica, per noi europei non abituati a marciapiedi così ampi, se non sugli Champs-Élysées. Camminiamo e pensiamo a film come ‘Un uomo da marciapiede”, per esempio. Siamo all’interno di quella che è indiscutibilmente la realtà del nostro corpo, della nostra esperienza sensoriale, ma allo stesso tempo siamo dentro una finzione, paragonabile a quella che sperimentavamo giocando da ragazzini. Ed è curioso che molti, in Europa, abbiamo soprattutto giocato agli indiani e ai cowboy, scoprendo a posteriori tutta una serie d’ingiustizie politiche nel voler essere sempre i cowboy e mai gli indiani. È come se quella percezione degli Stati Uniti che abbiamo fatto nostra già durante il gioco non si potesse mai del tutto consumare, smaltire. Gli Stati Uniti esistono e sono una grande esperienza di finzione.
È questa sensazione che ha portato quello che doveva essere un reportage a divenire finzione?
In parte. Io inizio con l’intenzione di scrivere un canonico reportage, una scrittura che non sia di finzione, una scrittura in cui ci sono persone e non personaggi e in cui perlopiù si fa un resoconto di quello che si è visto, di quello che è accaduto. E invece mi ritrovo a scrivere un libro a tutti gli effetti di finzione, in cui le persone sono subito spostate sul piano dei personaggi, a partire da uno stimolo con il quale non era possibile venire a patti. E cioè che quel viaggio è percorso con chi nel libro si chiama Silva, l’editore che ci accompagna attraverso gli spazi abbandonati degli Stati Uniti, e con Ramak Fazel, un fotografo americano di origini iraniane che conosco soltanto il primo giorno di viaggio e del quale non so nulla. Scopro che Ramak è una persona con attitudine a essere personaggio, allo sconfinamento, a un’intraprendenza gentile ma allo stesso tempo incoercibile, che mi fa capire che gli devo andare dietro. Io tendo a restare al di qua e invece ho il privilegio di viaggiare con qualcuno che cerca sempre di andare al di là. Nel libro si compenetrano quindi alcune cose accadute e altre inventate, senza mai segnalare cos’è successo nella cosiddetta realtà e cosa è stato immaginato ad hoc.
Quello con Ramak è stato a tutti gli effetti un appuntamento al buio…
Un appuntamento al buio che poi si è trasformato in un’amicizia che va avanti da sette anni e che ha visto una seconda collaborazione nell’autunno del 2016, quando ci siamo ritrovati laddove avevamo interrotto il viaggio del 2013. Ci eravamo salutati a Houston, in Texas, per rivederci lì tre anni dopo, questa volta viaggiando insieme non per scrivere un libro ma per realizzare reportage per i giornali sul tema della provincia americana subito prima delle elezioni dell’8 novembre 2016, vinte inaspettatamente da Donald Trump. Inaspettatamente per l’Europa e le grandi città americane. Durante il nostro viaggio abbiamo incontrato soltanto l’elettorato americano. Abbiamo, come abitualmente si fa negli Stati Uniti, acquistato un’automobile al volo, quelle cose tanto strane per noi europei, per rivenderla nel giro di due settimane, scrivendo sul tergilunotto ‘For sale’ e venendo contattati dai potenziali acquirenti, trasformando anche questi appuntamenti per la valutazione del mezzo in occasioni di racconto della gente incontrata risalendo lungo il Mississippi e poi percorrendo il Midwest fino ad arrivare a New York la notte delle elezioni. In quell’occasione, di nuovo attraverso l’intraprendenza di Fazel, siamo entrati in luoghi nei quali non avevamo nessun titolo per stare, come l’Hilton che ospitava il quartier generale repubblicano, una specie di punto vista privilegiato per accorgersi di quello che stava succedendo.
In più d’uno hanno citato ‘Absolutely nothing’ durante il lockdown o lo fanno ora con riferimento allo stesso. Mai, in fondo, siamo stati così vicini ai luoghi dell’abbandono. Mai come negli scorsi mesi ne siamo stati cittadini. Qual’è stata la sensazione per chi ha conosciuto i deserti?
Una prima differenza rispetto alla percezione che possiamo avere dei deserti noi europei è l’utilizzo della parola ‘deserto’ come aggettivo iperbolico, per chiarire che in un luogo non c’è nessuno. Quella strada è ‘deserta’, quel posto è ‘deserto’. Per me ‘deserto’ è diventato pienamente un sostantivo quando i deserti li ho attraversati. Nel periodo del lockdown mi affacciavo come chiunque, guardando lo spazio cittadino e lo vedevo vuoto. Questo aveva in me produceva un contraccolpo traumatico ma anche qualcosa di stranamente affascinante: mi accorgevo del fatto che non abbiamo mai visto così le nostre città se non alle cinque, alle sei del mattino. Abbiamo visto un’alba che non finiva mai, durata due mesi. Quello che dell’alba canonica ci affascina è che è un transito, una soglia, un momento di quasi verginità dello spazio e del tempo, di estrema pulizia. Poi arrivano un passante, una macchina, un ragazzino che attraversa la strada per andare a scuola, e lo spazio si anima e questo ci rassicura. Quest’alba ininterrotta ci ha messo senz’altro alla prova da un punto di vista sensoriale, cognitivo e immaginativo.
Ha messo alla prova anche lei, come scrittore?
Le risponderò pensando ai primi giorni, settimane, È capitato di sentire amici scrittori chiedersi “E adesso come faccio?”. Qualcuno aveva un romanzo iniziato, con un’ambientazione contemporanea. Come continuarlo? La sensazione che avevo era che non ci fosse da preoccuparsi. Tutto quello che è accaduto agisce e agirà al di là delle nostre intenzioni, perché ha riformato delle percezioni originarie. La nostra percezione dello spazio è soprattutto la distanza dei corpi, che non leggevamo più perché resa complessivamente innocua dal racconto sociale. I fenomeni più significativi pre-lockdown in Italia sono stati la movida, che fonda se stessa sulla riduzione al minimo se non sull’eliminazione della distanza tra i corpi, e poi il fenomeno delle Sardine, movimento che già dal nome voleva rappresentare un'idea di polemica, di protesta attraverso la riduzione della distanza tra i corpi, che per me è un fatto misterioso, complesso. Quanto è accaduto, a mio parere, ha ripristinato un rispetto – seppur in questo momento soprattutto a partire da criteri sanitari – nei confronti dell’alone che sta intorno a ogni corpo. Aloni che, quando collidono, non è che ora non producano più effetti, ma continuano a garantire collisioni silenziose che sono esperienza. Forse ora ci potrà essere più attenzione e rispetto per tutto questo. Anche se ho l’impressione che stiamo rapidamente facendo un lavoro sull’oblio. Ed è un peccato. Non perché il desiderio da parte mia sia quello di uno stato di emergenza permanente, ma perché forse il giusto rispetto per quello che è successo, e per chi di questo è morto, passa anche dal non pretendere di ritornare. Non si tratta di ripristinare una condizione interrotta a metà marzo. Si tratta di andare proprio da un’altra parte.