Deborah Feldman, perdere l'innocenza
Una donna che con difficoltà ha abbandonato la comunità chassidica di Brooklyn dove è nata e cresciuta (bestseller in italiano grazie alla ticinese Abendstern)
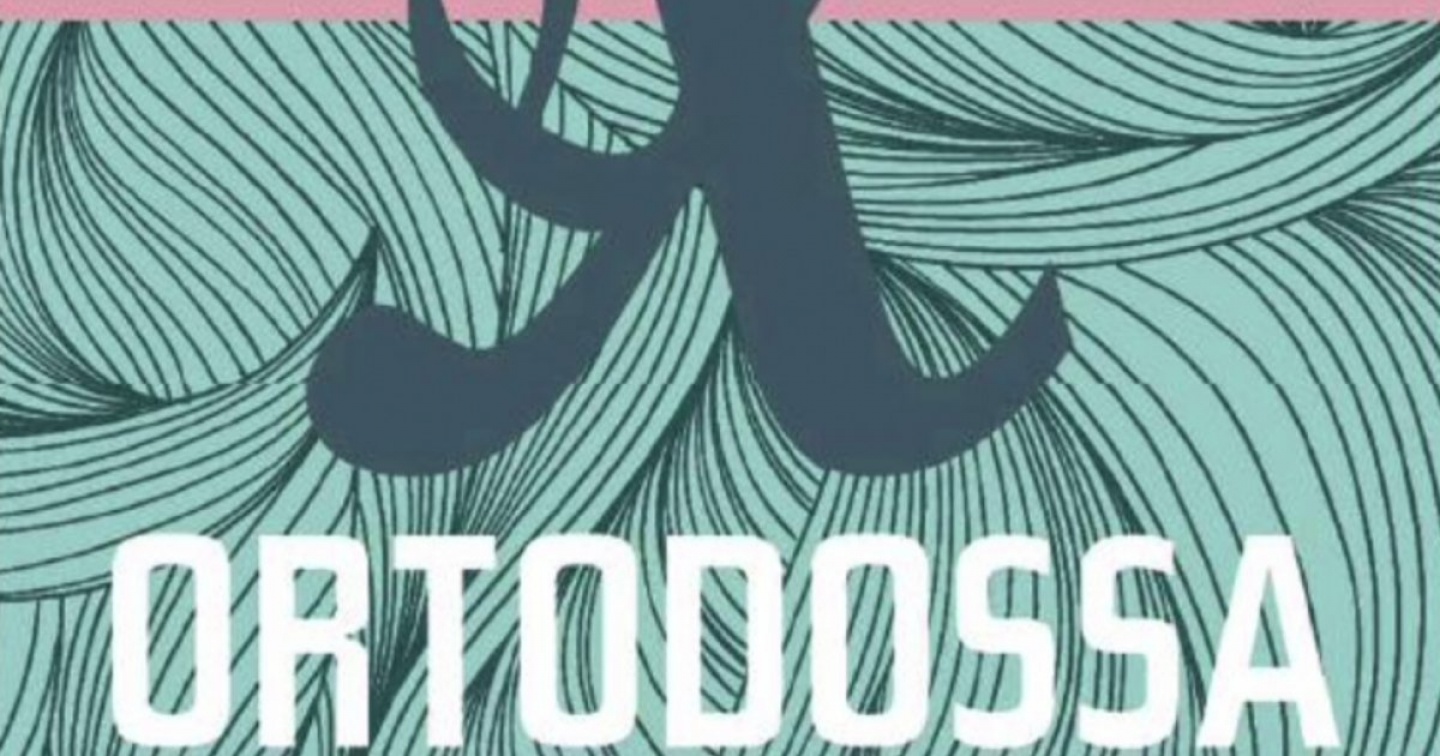
Anch’io ho dei segreti. Forse Bubby li conosce, ma non dice niente dei miei fintanto che io non parlo dei suoi. O forse la sua complicità me la sono solo immaginata; è possibile che questo accordo sia unilaterale. Chissà se Bubby spiffererebbe i miei segreti. Io nascondo i miei libri sotto il letto, lei nasconde i suoi tra la biancheria, e una volta all’anno, quando prima della Pesach Zeidy ispeziona la casa frugando tra le nostre cose, ci aggiriamo in preda al panico, nel terrore di essere scoperte.
Zeidy fruga addirittura nel mio cassetto della biancheria. Desiste solamente quando gli dico che quelle sono cose private femminili, infatti non vuole violare la privacy di una donna e dunque passa all’armadio di mia nonna. Quando fruga fra la sua biancheria, anche lei si mette sulla difensiva. Sappiamo entrambe che la nostra minuscola pila di libri secolari scandalizzerebbe mio nonno ancor più di una catasta di chametz, i cibi lievitati che a Pasqua sono proibiti. Bubby probabilmente se la caverebbe con un rimprovero, ma a me il nonno non risparmierebbe tutta la sua ira. Quando il mio zeide si arrabbia, la sua lunga barba sembra sollevarsi ed espandersi su tutta la faccia come una fiamma ardente. Nel calore del suo sdegno mi raggelo all’istante.
«Der tumeneh shprach!» tuona verso di me, quando sente che parlo ai miei cugini in inglese. Zeidy dice che una lingua impura agisce sull’anima come un veleno. Leggere un libro in inglese è ancora peggio, rende la mia anima vulnerabile, è come invitare il diavolo a entrare.
Oggi non sono in me, il che spiega il mio lapsus. Sotto il mio materasso c’è qualcosa di nuovo e presto (non appena Bubby non avrà più bisogno di me per i kreplach) chiuderò la porta della mia camera e aprirò quel meraviglioso volume rilegato in cuoio con il suo entusiasmante profumo di libro nuovo. È una parte del Talmud nella versione inglese proibita, è lungo migliaia di pagine e dunque promette settimane di lettura appassionata. Non riesco ancora a credere che sarò finalmente in grado di decodificare antichi discorsi talmudici pensati apposta per escludere gli ignoranti come me. Zeidy non mi lascia leggere i libri ebraici che tiene sottochiave nel suo armadio, dice che sono solo per gli uomini, il posto delle donne è in cucina. Ma io sono curiosa riguardo ai suoi studi e a cosa esattamente c’è scritto nei libri su cui sta chino per ore di fila con l’estasi fremente di un accademico.
Le briciole di saggezza diluita che i maestri ci mettono a disposizione a scuola servono solo ad accrescere la mia fame. Voglio conoscere la verità su Rachel, la moglie del rabbino Akiva, che per dodici anni si occupò della propria casa in povertà mentre il marito studiava la Torah in qualche terra straniera. Come è possibile che la figlia viziata di un uomo ricco si fosse rassegnata a una tale miseria? Le mie maestre dicono che fosse una santa, ma la storia dev’essere più complicata. Tanto per cominciare, perché avrebbe dovuto sposare un uomo povero e ignorante come Akiva? Di sicuro non perché era bello, altrimenti non avrebbe accettato quel viaggio che è durato dodici anni. Dev’esserci una ragione, e se nessuno vuole dirmela la scoprirò da sola.
La settimana scorsa ho comprato la traduzione Schottenstein del Talmud da Judaica, a Borough Park. Il negozietto era vuoto, illuminato solo dai deboli filamenti di sole che filtravano dalle vetrine sporche. Il laniccio argentato sembrava soQuando speso nei fasci di luce e fluttuava lentamente verso il soffitto guidato dalla forza di un debole spiffero proveniente dal condotto del riscaldamento. Nascosta all’ombra degli scaffali traballanti, avevo farfugliato al venditore che il libro era per mio cugino e che mi era stato chiesto di comprarlo per lui. Mi chiedevo se il mio nervosismo fosse visibile; di sicuro la menzogna ce l’avevo scritta in fronte, proprio come mi ammoniva sempre Zeidy: «Der emes shteit oif di shteren» mi diceva. «Non importa con quanta convinzione tu menta, la fronte ti tradisce sempre». Immaginavo le parole incise sulla pelle risplendere al buio come una luce al neon, mentre una brezza improvvisa sollevava la mia frangetta castana.
Nella piccola libreria di New Utrecht Avenue lavora un uomo solo, come ho potuto accertare durante i numerosi giri di ricognizione che ho fatto. È vecchio, gli tremano le mani e sbatte le palpebre di continuo; anche dopo che aveva avvolto il libro grosso e squadrato nella carta marrone, non riuscivo ancora a credere di averla fatta franca. Forse quel tizio non era capace di leggere le fronti, oppure ero riuscita a sembrare stupida, mantenendo un’espressione vacua e spenta. Ha preso i miei sessanta dollari, per lo più in pezzi da uno, guadagnati facendo la baby sitter, e li ha contati lentamente prima di annuire con un cenno del capo. Poi ha detto «It’s gut», potevo andare.
Ho cercato di uscire dal negozio con nonchalance e solo dopo avere percorso l’intero isolato ho cominciato a saltellare per l’incontenibile felicità. Mentre tornavo a Williamsburg in autobus, mi tremavano le ginocchia: era il fremito illecito per ciò che era appena successo. Sicuramente tutti potevano accorgersi della mia malefatta. Gli uomini erano seduti nei posti davanti, con lo sguardo fortunatamente altrove, ma le donne, con le loro teste avvolte nei fazzoletti e le calzamaglie coprenti, sembravano rivolgere sguardi d’accusa a me e al grosso pacco che portavo in grembo.
Mentre camminavo lungo Penn Street, stringevo al petto il pacco di carta marrone, le gambe malferme ed elettrizzate per il miscuglio di paura e trionfo. Evitavo gli sguardi dei passanti, terrorizzata all’idea di imbattermi in qualche vicino sospettoso. E se qualcuno mi avesse chiesto cosa stavo portando? Evitavo i ragazzini che passavano sfrecciando sulle loro biciclette malandate, e le adolescenti che spingevano i fratelli più piccoli nelle carrozzine cigolanti. In quella tiepida giornata primaverile erano usciti proprio tutti, e l’ultimo pezzo di isolato sembrava non finire mai.
Una volta arrivata a casa, mi sono affrettata a nascondere il libro sotto il materasso spingendolo in profondità, non si può mai sapere. Ho lisciato lenzuola e coperte arrangiando il copriletto in modo che sfiorasse il pavimento. Mi sono seduta sul bordo del letto e ho lasciato che il senso di colpa mi travolgesse con una forza tale da inchiodarmi lì.
Volevo dimenticare quella giornata. Per tutto lo Shabbat il libro è rimasto a bruciare sotto il mio materasso, a tratti punendomi e a tratti attirandomi a sé. Ignoravo i suoi richiami: era troppo pericoloso, e in giro c’era troppa gente. Cosa avrebbe detto Zeidy se avesse saputo? Perfino Bubby sarebbe inorridita, ne ero certa. La domenica si dipana davanti a me come un kreplach non aperto, una giornata morbida e soffice con un ripieno segreto. Tutto quello che devo fare è aiutare Bubby a cucinare, poi sarò libera di passare il resto del pomeriggio come meglio credo.
Oggi Bubby e Zeidy sono stati invitati al Bar Mitzvah di un cugino, il che significa che avrò almeno tre ore di privacy ininterrotta. Nel frigorifero c’è ancora una fetta di torta al cioccolato di cui sono sicura che Bubby, a causa della sua memoria instabile, non noterà la mancanza. In un pomeriggio come questo, cosa potrei chiedere di meglio? il rumore dei passi pesanti di Zeidy che scende le scale svanisce, e dalla finestra di camera mia, al secondo piano, vedo i nonni entrare nel taxi, prendo il libro da sotto il materasso e lo poso sulla scrivania con riverenza. Le pagine di carta cerata traslucida sono fitte di testo: le parole originali del Talmud, la loro traduzione in inglese, e i commentari rabbinici che occupano la metà inferiore di ogni pagina. Meglio di tutto sono le discussioni, ossia le trascrizioni dei dibattiti dei vecchi maestri rabbini su ogni frase sacra del Talmud.
A pagina sessantacinque i rabbini discutono di re Davide e della moglie Betsabea che ha ottenuto col peccato e con l’inganno, un racconto biblico ammantato di mistero che mi ha sempre incuriosita. Dai frammenti citati risulta che quando Davide posò gli occhi su di lei, Betsabea fosse già sposata con Uria. Egli però ne era attratto al punto da arrivare a mandare il marito Uria al fronte così che cadesse in guerra, lasciando Betsabea libera di risposarsi. Poi però, quando Davide infine prese Betsabea come moglie legittima e la guardò negli occhi, nelle sue pupille vide il riflesso del proprio peccato e provò ripulsione. Da quel momento Davide non volle mai più vedere Betsabea, la quale trascorse il resto della vita nell’harem del re, ignorata e dimenticata. Ora capisco perché non mi è permesso leggere il Talmud. Le mie insegnanti mi hanno sempre detto e ripetuto che «Davide era senza peccato. Davide era un santo. È proibito spargere calunnie sul beneamato figlio di Dio, sovrano per diritto divino». E sarebbe lo stesso illustre antenato cui fa riferimento il Talmud?
Scopro che re Davide non si limitava a fare festa con le sue numerose mogli, ma aveva anche delle compagne non sposate. Le chiamano concubine. Sussurro ad alta voce questa nuova parola, con-cu-bi-na, e non suona immorale come dovrebbe, mi fa semplicemente pensare a un albero alto e maestoso. L’albero delle concubine. Immagino donne meravigliose pendere dai suoi rami. Con-cu-bi-na.
Betsabea non era una concubina perché re Davide l’aveva onorata prendendola in moglie, ma secondo il Talmud era l’unica donna che il re aveva scelto pur non essendo una vergine. Allora mi viene in mente la bellissima donna sulla bottiglia dell’olio d’oliva, l’extravergine. I rabbini dicono che Dio volesse solo vergini per Davide, e che restando con Betsabea, la quale era già stata sposata, il re avrebbe compromesso la sua santità.
Secondo loro re Davide è il termine di paragone con cui tutti noi verremo giudicati in cielo. Ma allora, quanto potrà costarmi la mia piccola scorta segreta di libri in inglese, se paragonata alle concubine?
Lì per lì non mi rendo conto di avere perso la mia innocenza. Lo capirò solo molti anni dopo. Un giorno, ripercorrendo il mio passato, mi accorgerò che proprio come c’è stato un momento della vita in cui ho preso coscienza del mio potere, ce n’è stato anche un altro ben preciso in cui ho smesso di credere nell’autorità solo per il piacere di farlo, e ho cominciato a trarre le mie personali conclusioni sul mondo in cui vivevo.
In seguito alla perdita dell’innocenza mi diventò sempre più difficile continuare a fingere. Dentro di me ribolliva un profondo conflitto tra i miei pensieri e gli insegnamenti che ricevevo. Succedeva di tanto in tanto che la tensione traboccasse, incrinando la mia facciata di tranquillità, ma a quel punto qualcuno era sempre pronto ad allontanarmi dalle fiamme della curiosità prima che mi spingessi troppo oltre.
di Deborah Feldman (traduzione di Daniela Marina Rossi e Simona Sala)
L’autrice
Nata nel 1986 nella comunità chassidica Satmar di Williamsburg, Brooklyn. Cresciuta dai nonni paterni, sin da piccola deve attenersi alle severe regole della comunità ultraortodossa. Dopo un matrimonio combinato e la nascita del figlio, inizia a studiare di nascosto letteratura; in seguito dà vita a un blog, trampolino di lancio del bestseller ‘Unorthodox’, trovando così la forza di abbandonare per sempre la comunità. È una delle protagoniste del documentario di Barbara Miller ‘#FemalePleasure’.





